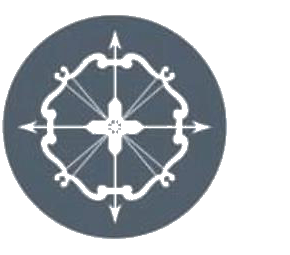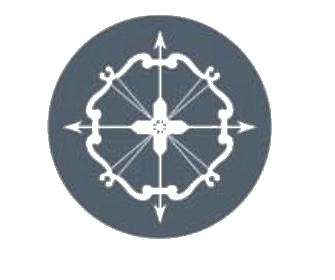Resta Aggiornato sul Mondo Legale
Il diritto è in costante evoluzione. Iscriviti ora e assicurati di non perdere mai un aggiornamento importante.
Con questo articolo, si intende fornire una sintesi degli strumenti legali, in favore delle famiglie al cui interno vi siano dei soggetti affetti da patologie mentali.
Il sostegno per i malati mentali e soprattutto per i familiari è fondamentale per tutelare i loro diritti e garantire l’accesso a cure adeguate.
Oltre a fornire una panoramica sugli strumenti legali messi a disposizione del Legislatore, si cercherà di condividere, tramite esperienze sul campo, i gravissimi problemi che figli e genitori possono subire a causa di dinamiche familiari deteriorate, che determinano insicurezze ed errori.
Senza voler entrare negli ambiti psicologici e psichiatrici di competenza di specifici settori, cercheremo di individuare il ruolo e la figura dell’avvocato, il quale appare sempre più strategico per coordinare i vari soggetti che possono essere coinvolti, strutturando e pianificando con specifici interventi un programma di protezione e di cura in favore dei soggetti beneficiati e dei familiari.
Le famiglie possono trovarsi in difficoltà e spesso in conflitto di interessi nel gestire comportamenti pericolosi e violenti di un parente con patologie mentali.
È noto infatti che le malattie mentali possano influenzare la capacità di intendere e volere, che è fondamentale per prendere decisioni personali e sanitarie, oltre a tutelare eventuali patrimoni e sottrarre i malati ad abusi o truffe, oltre a non sottoporsi ad una adeguata assistenza sanitaria.
Oltre agli aspetti sopraindicati, le patologie cognitive possono in alcuni casi determinare discriminazioni nell’ambito lavorativo e aggravare situazioni di conflitto nella gestione dei figli e nella divisione dei patrimoni.
Strumenti legali
Vediamo ora i principali Istituti che si possono utilizzare per prevenire ed arginare problematiche più gravi, nonché per mettere in protezione le famiglie.
L’Amministratore di Sostegno (AdS)
Vediamo ora i principali istituti che si possono utilizzare per prevenire ed arginare problematiche più gravi, nonché per mettere in protezione le famiglie.
La Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 rappresenta, in questo contesto, la forma di tutela più agile nei procedimenti che verranno di seguito descritti. Tale norma ha modificato in parte gli istituti preesistenti, l’Interdizione e l’Inabilitazione, a tutela del soggetto incapace, introducendo nuove norme espresse in venti articoli, trattate unitamente alle precedenti, al Titolo XII del Libro I del Codice Civile, denominato: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia».
L’art. 3 della Legge n. 6/2004 ha spostato l’attenzione dalla tutela dei beni materiali alla tutela della persona. Il 1° comma dell’art. 408 c.c. recita che «La scelta dell’Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario».
Il legislatore ha inteso configurare l’Amministratore di Sostegno come uno strumento versatile, personalizzato sulle esigenze del caso concreto, ove la maggiore attenzione va riservata alla riduzione dell’autonomia sul versante del fare.
Il ricorso all’AdS rappresenta una parte integrante di un progetto di cura più ampio, assistenza e sostegno alla persona fragile, che prevede la costituzione di una rete di relazioni che coinvolge:
- Il Giudice Tutelare, responsabile di direzione, coordinamento, verifica e controllo.
- I medici curanti del Dipartimento di Salute Mentale, incaricati di redigere progetti terapeutici-riabilitativi personalizzati.
- L’Amministratore di Sostegno, garante degli interessi del beneficiario e interlocutore privilegiato dell’équipe del Dipartimento di Salute Mentale.
- Il beneficiario e i familiari, parte integrante del progetto terapeutico.
Problematiche comuni
Sulla base delle esperienze sul campo, emerge che il peggioramento di molti casi clinici è spesso dovuto alla mancata continuità delle terapie, determinata dal rifiuto di aderire alle cure prescritte.
L’acquisizione del consenso informato alle cure è un atto fondamentale della prassi medica. Anche il paziente affetto da patologia psichiatrica ha il diritto di esprimere il proprio consenso o dissenso alle cure, fatta eccezione per le situazioni in cui è necessario ricorrere al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), riservato alla fase acuta di malattia.
Al di fuori di tale momento, lo psichiatra, in presenza di soggetti con scarsa o assente coscienza di malattia, si trova nella difficoltà di bilanciare il benessere del paziente con il principio di autonomia, che prevede il diritto all’autodeterminazione nelle cure.
Applicazioni tipiche
Un caso classico che prevede il ricorso per la nomina di un AdS è rappresentato dalla demenza, una patologia degenerativa che comporta la perdita progressiva dell’autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana.
Ne consegue che il soggetto affetto da demenza avrà bisogno di livelli crescenti di assistenza, che supportino e surroghino le sue ridotte capacità di cura di sé e di tutela dei propri interessi.
Trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O)
Il T.S.O. indica il “Trattamento Sanitario Obbligatorio”, una procedura sanitaria che sottopone un individuo a cure mediche contro la sua volontà. Il riferimento normativo è rappresentato dagli articoli 33, 34 e 35 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978.
Condizioni di applicazione
Il T.S.O. è prevalentemente associato al campo psichiatrico, ma può essere applicato anche ad altre condizioni mediche, come alcune malattie infettive. Secondo il Ministero della Giustizia (2015), può avvenire in regime di degenza ospedaliera solo:
- In presenza di alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici.
- Se il paziente rifiuta volontariamente le cure necessarie.
- Quando non esistono alternative extraospedaliere tempestive e idonee.
Procedura
Il T.S.O. viene disposto con un provvedimento motivato del sindaco del comune di residenza o di quello dove si trova temporaneamente il soggetto. La procedura prevede:
- Proposta e convalida: Il trattamento è proposto da un medico e convalidato da un altro medico della ASL.
- Ordinanza del sindaco: Prevede l’accompagnamento del paziente da parte della polizia locale e dei sanitari presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).
- Trasmissione al Giudice Tutelare: Il provvedimento deve essere convalidato o revocato dal Giudice Tutelare.
Se il T.S.O. non viene convalidato, il sindaco deve disporne l’immediata cessazione.
Ricorsi e diritti
La legge prevede che qualsiasi persona interessata possa chiedere al sindaco la revoca o modifica del provvedimento. La persona sottoposta al T.S.O., o chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare.
Il T.S.O. rappresenta un intervento eccezionale e regolato da normative specifiche, volto alla cura e alla riabilitazione di pazienti in condizioni psichiatriche acute e urgenti che rifiutano le cure necessarie. Tuttavia, comporta importanti implicazioni legali e psicologiche, inclusa la necessità di ricostruire fiducia e alleanza tra medico e paziente per ripristinare la capacità del soggetto di prestare consenso alle cure.
Istituto dell’Interdizione
L’Istituto dell’Interdizione, disciplinato dagli articoli 414 e seguenti del Codice Civile, rappresenta una misura di tutela destinata a proteggere soggetti con gravi e permanenti condizioni di incapacità.
Destinatari e Presupposti
L’interdizione si applica a:
- Maggiorenni.
- Minori emancipati.
- Minori nell’ultimo anno di età.
Per la pronuncia di interdizione, è necessario accertare:
- Abituale infermità mentale: Alterazione permanente o continuativa delle facoltà mentali. Questa deve essere:
- Attuale: Non rilevano episodi pregressi se il soggetto mostra miglioramenti significativi.
- Grave: Deve comportare un’incapacità assoluta.
- Incapacità di provvedere ai propri interessi: Intesa come impossibilità di gestire sia aspetti economici sia la cura personale.
Effetti della Pronuncia
Con l’interdizione:
- Il beneficiario perde la capacità di agire sia per atti di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.
- Si applicano le disposizioni sulla tutela dei minori.
- Gli atti compiuti senza autorizzazione possono essere annullati su richiesta del tutore o di altri soggetti legittimati.
Ruolo del Tutore
Alla dichiarazione di interdizione, il soggetto è affidato a un tutore designato secondo queste priorità:
- Beneficiario stesso, tramite atto pubblico.
- Genitore superstite, anche tramite testamento.
- In assenza di indicazioni, dal Giudice Tutelare, che privilegia:
- Coniuge non separato.
- Parenti entro il quarto grado.
Il tutore ha il compito di rappresentare legalmente l’interdetto, curarne salute e sicurezza, amministrare il patrimonio e compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Cessazione dell’Ufficio di Tutore
Il ruolo del tutore può terminare per:
- Esonero o sostituzione: In caso di incarico gravoso.
- Rimozione: Per abuso, negligenza o incapacità, su disposizione del Giudice Tutelare.
Conclusioni
Come abbiamo visto l’orientamento legislativo è sempre più rivolto alla cura ed al benessere del beneficiario in relazione al pubblico interesse, affinché le famiglie possano rivolgersi ad enti ed associazioni territoriali per richiedere un supporto tramite specialisti del settore al fine di risolvere dinamiche famigliari sempre più complesse.
Articoli Legali Consigliati
Prenota ora